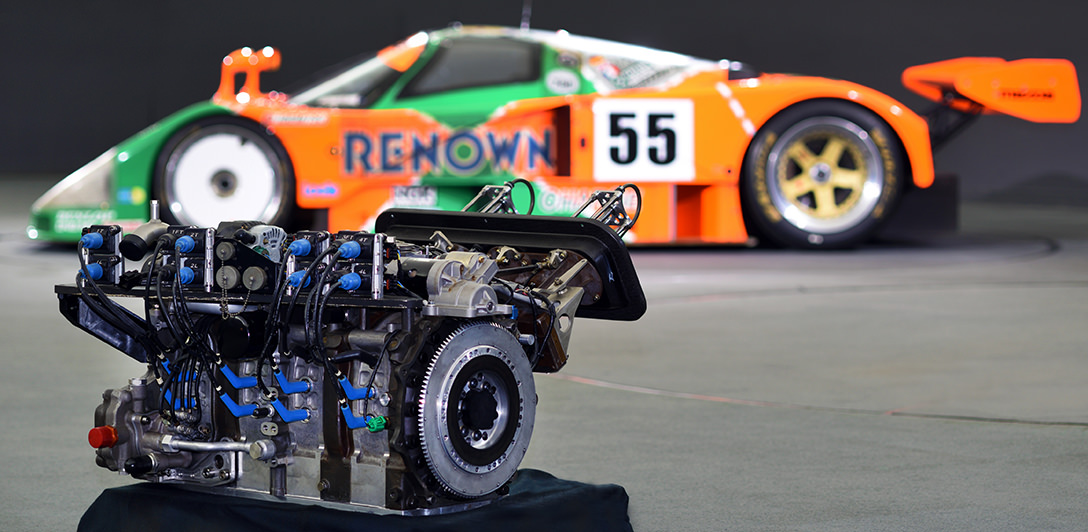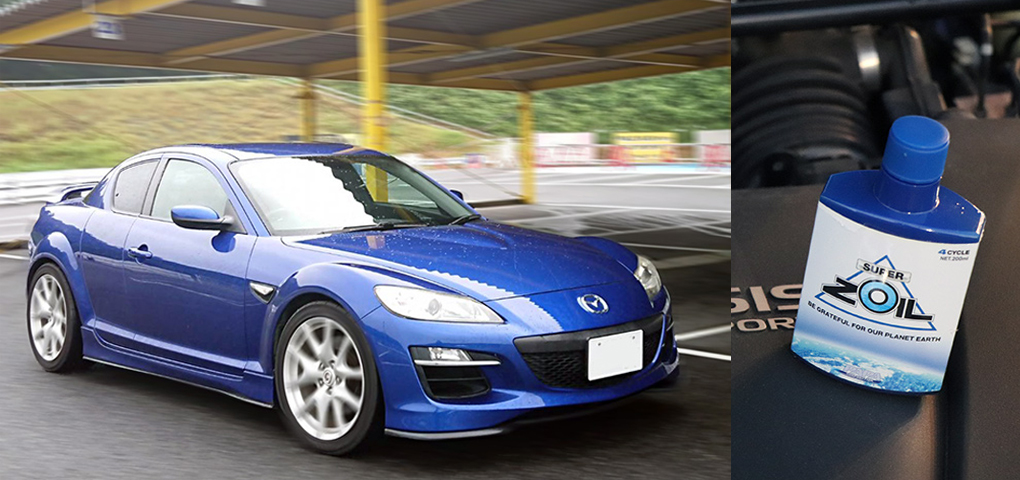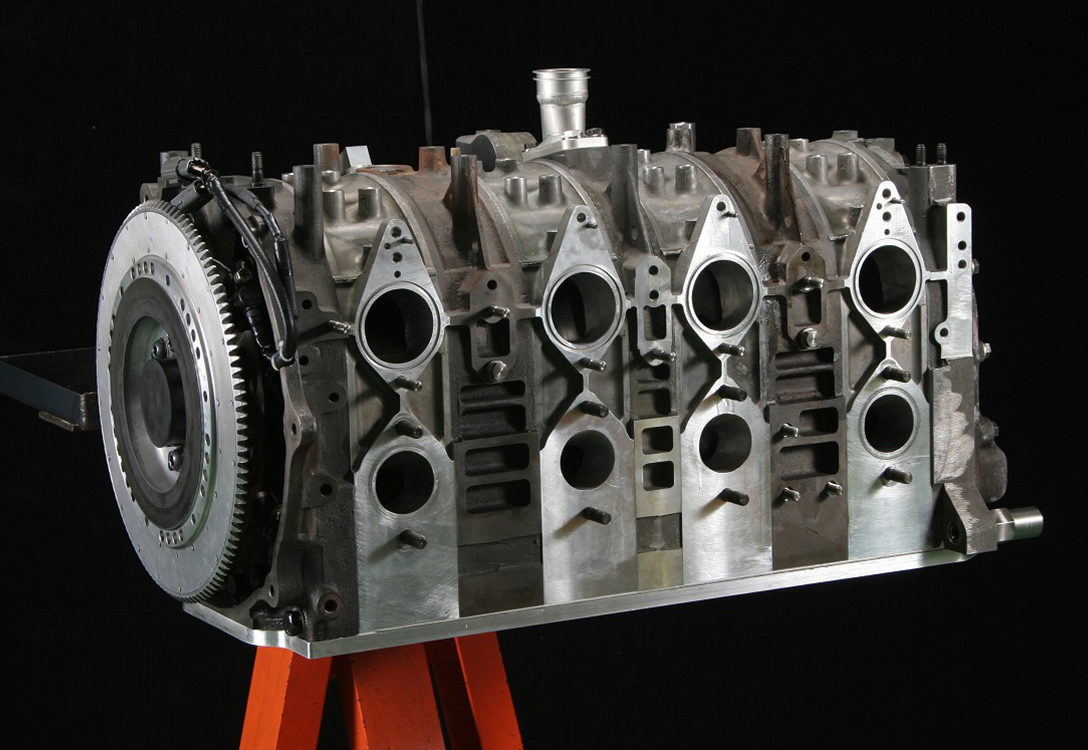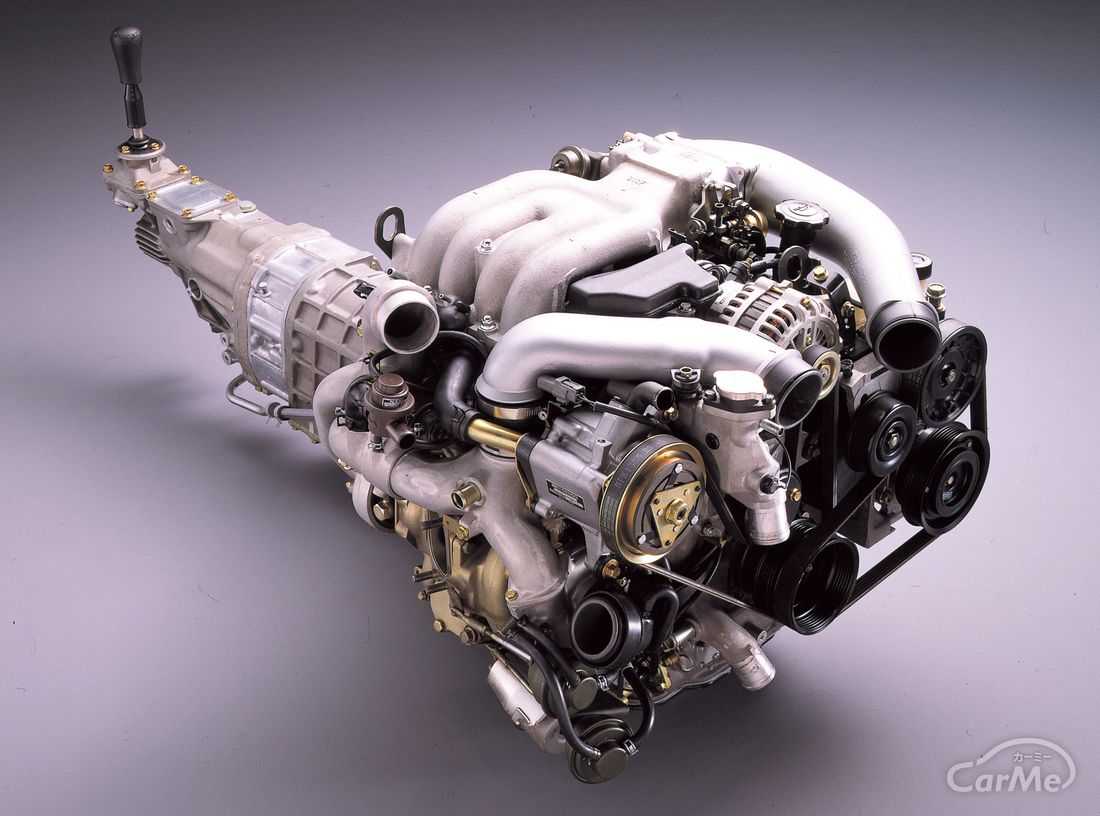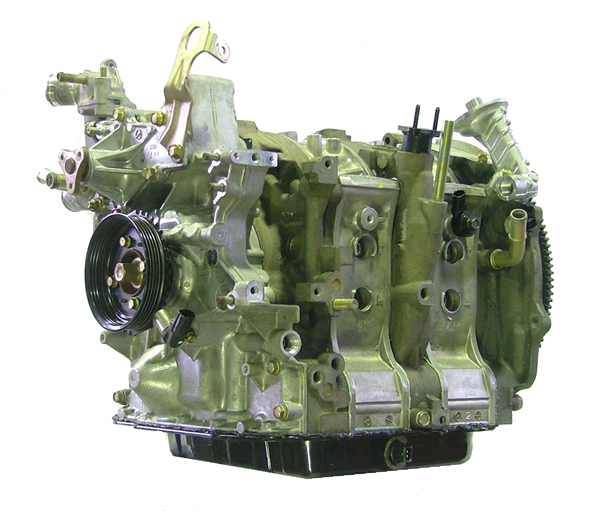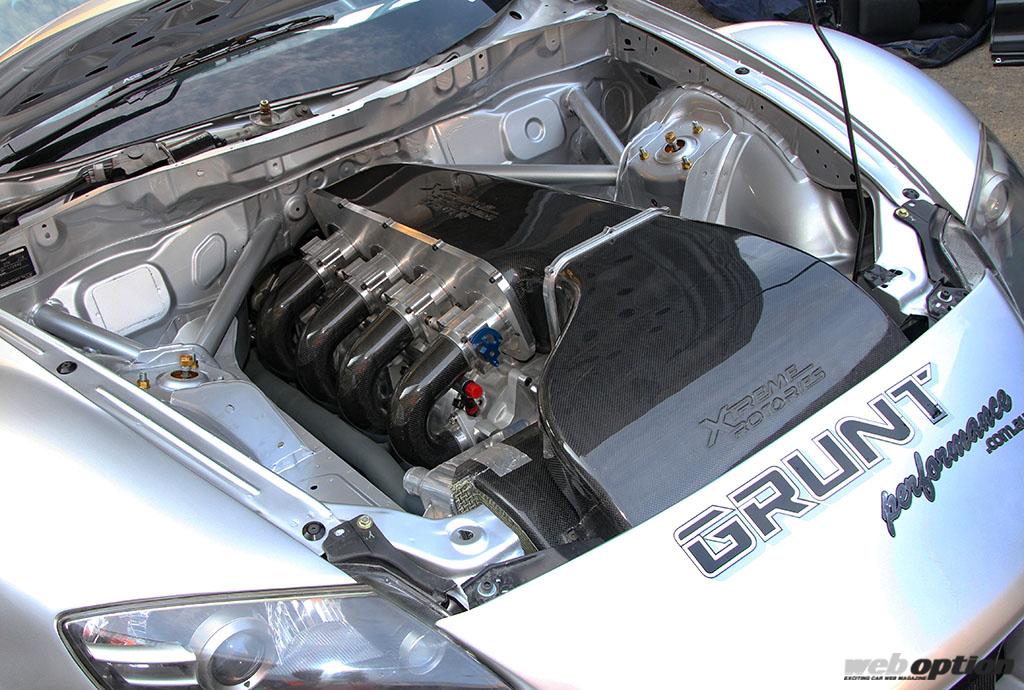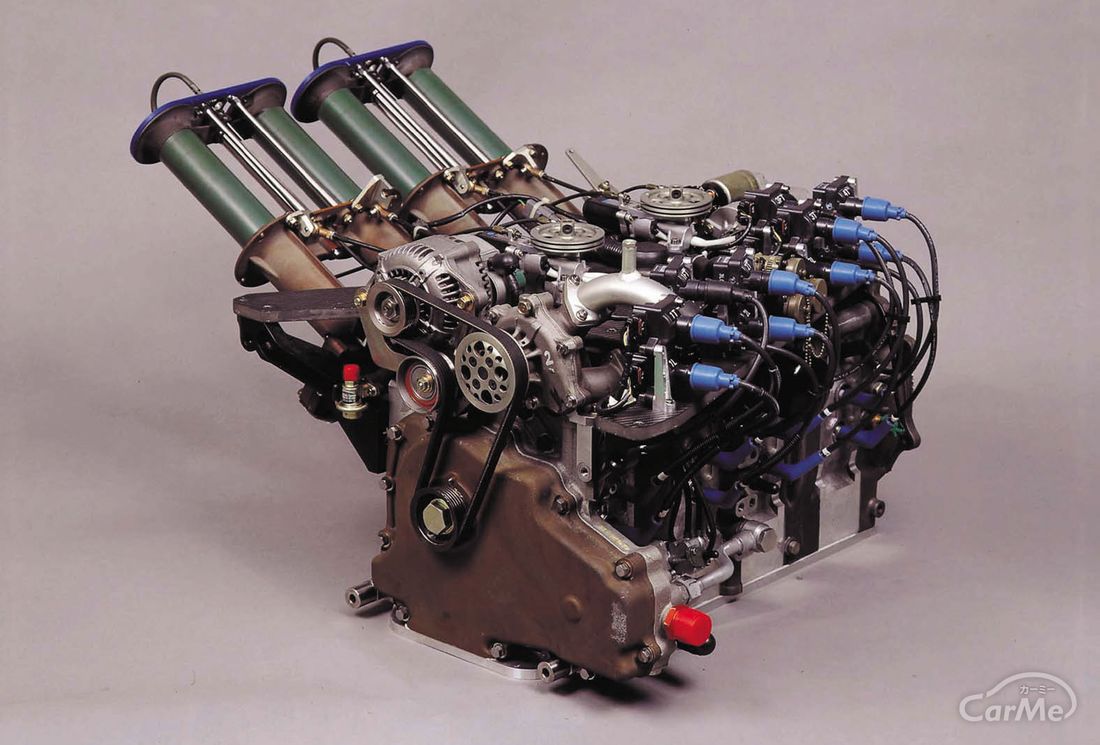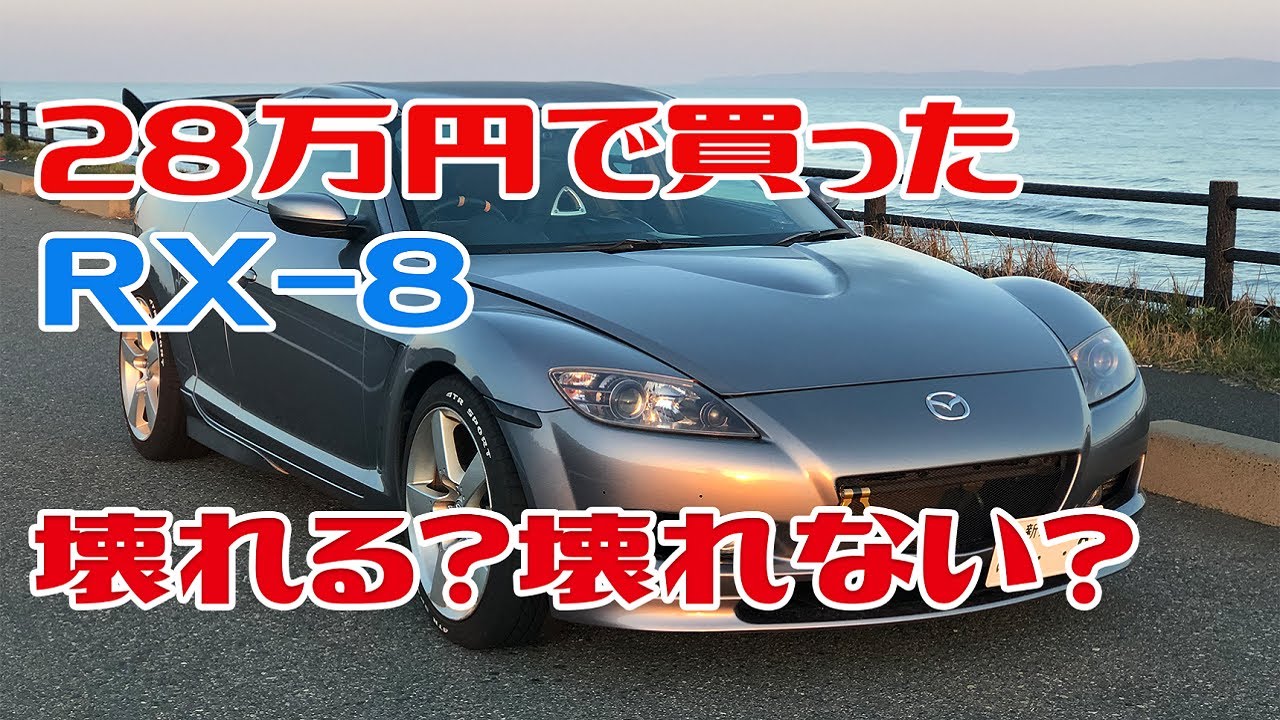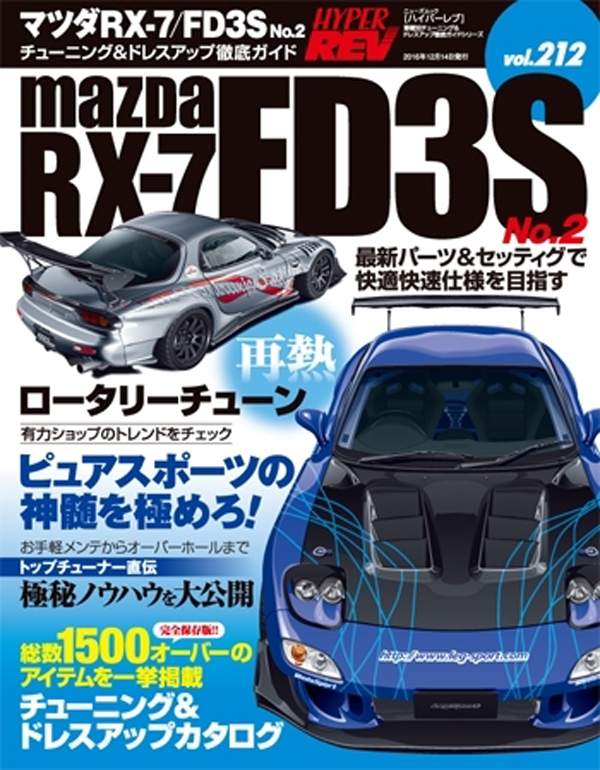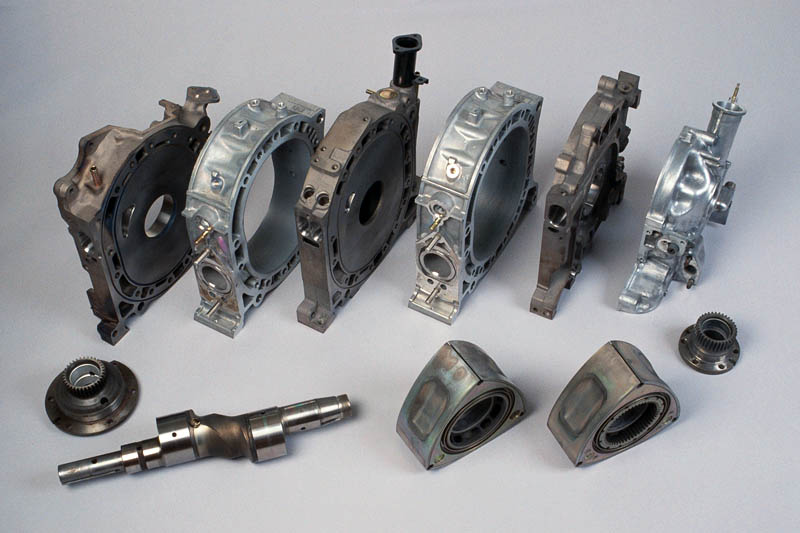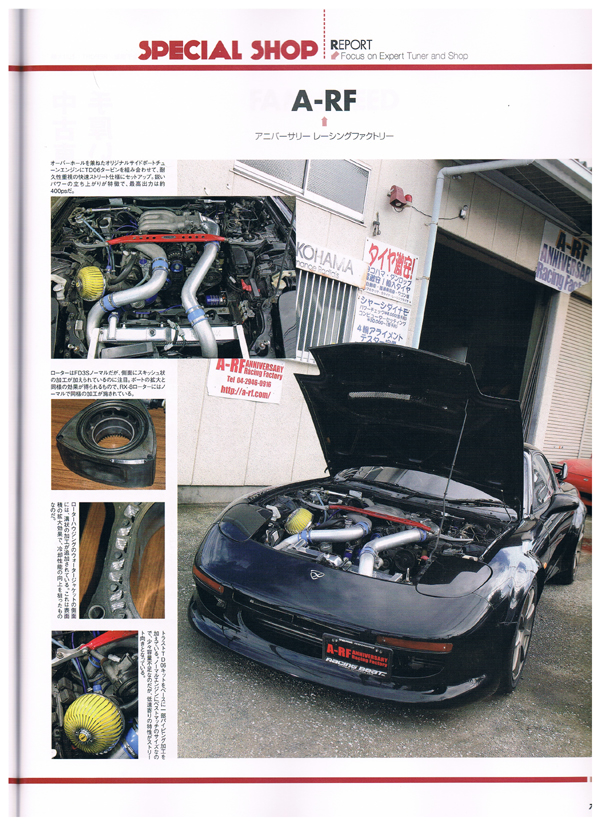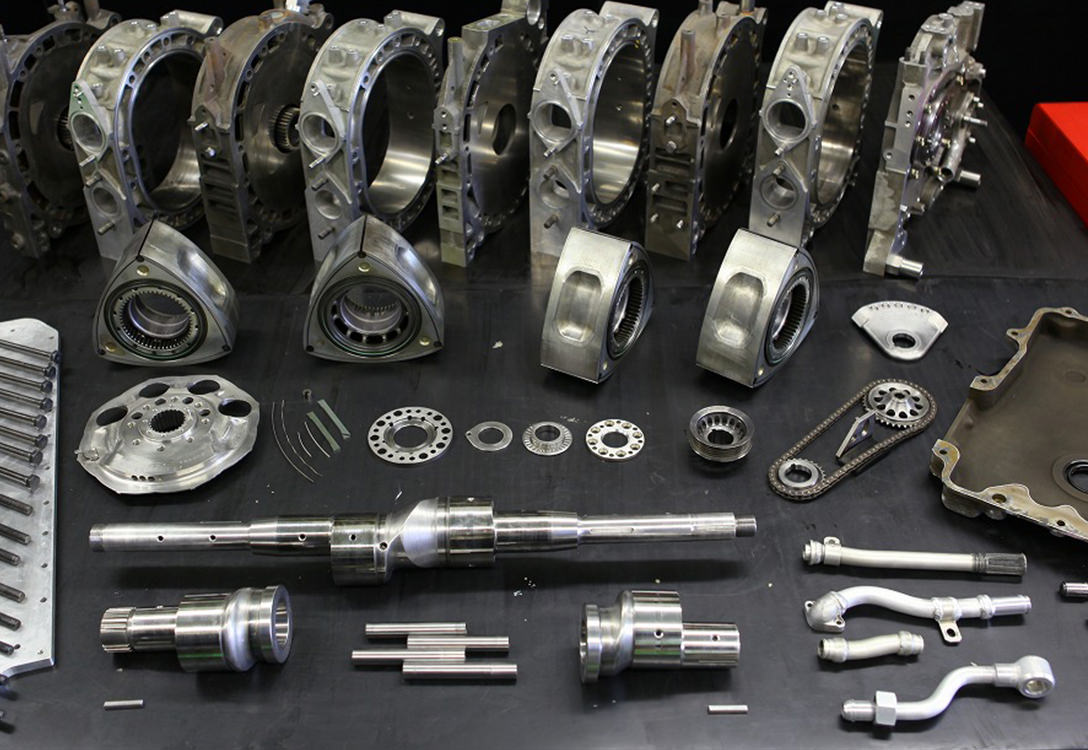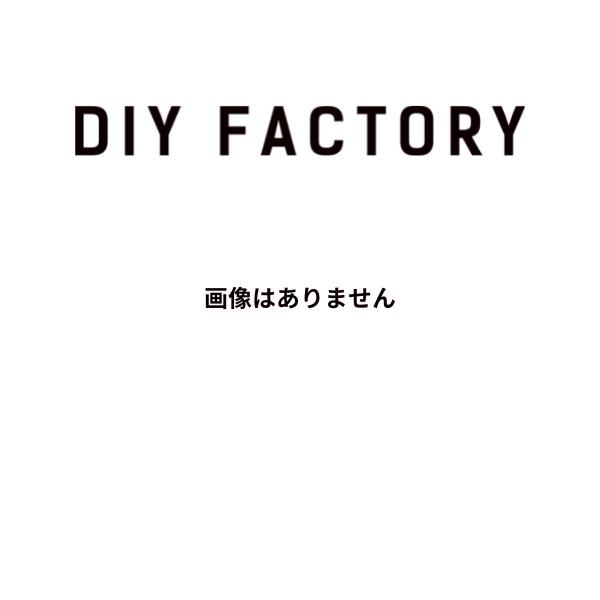RX 7 RX 8 RX 2 RX 3 RX 4対応プリミックスロータリーエンジン (4クォート)
(税込) 送料込み
商品の説明
商品情報
【商品名】
RX 7 RX 8 RX 2 RX 3 RX 4対応プリミックスロータリーエンジン (4クォート)
【商品説明】
適合ノート
なし23059円RX 7 RX 8 RX 2 RX 3 RX 4対応プリミックスロータリーエンジン (4クォート)車、バイク、自転車自動車本格スポーツカー”から”4ドアスポーツカー”へ!RX-7とRX-8はこう変わっ
ダイレクトフィット交換
Same As Factoryユニットをインストールします
オリジナルOE車両部品と同じ寸法…↓↓続きは商品情報欄も是非ご覧ください↓
※海外からのお取り寄せ商品の為、お届けまでに通常約2-3週間を頂戴しております。
※本商品新品・未使用商品ではございますが、税関にて開封や国際輸送時にパッケージにスレや傷がまれにある場合がございます。商品に問題はございませんので予めご了承くださいませ。トルク感は3ローター並!! マツダRX-7 ハイコンプロータリー×スーパー
R26B 4ローターロータリーエンジン
本格スポーツカー”から”4ドアスポーツカー”へ!RX-7とRX-8はこう変わっ
ロータリーエンジンにも有効なエンジントリートメント! オイル添加剤
RX-7,RX-8などRE車を中心にレースからフィードバックしたノウハウをも
R26B 4ローターロータリーエンジン
その咆哮は787Bそのもの!」伝説の4ローター搭載FD3Sに迫る | web
RX-7やRX-8など、ロータリーエンジンのオーバーホールは他のエンジンと
RX-7,RX-8などRE車を中心にレースからフィードバックしたノウハウをも
RX-7,RX-8などRE車を中心にレースからフィードバックしたノウハウをも
4ローターは当たり前、驚異の6ローター仕様も見参!」海外のチューンド
2ローターのロータリーエンジンを4ローターに変えたい!いくらかかる
RX-8(マツダ)の中古車 | 中古車なら【カーセンサーnet】
RX-8(マツダ)の中古車 | 中古車なら【カーセンサーnet】
ロータリーエンジンにも有効なエンジントリートメント! オイル添加剤
RX-8(マツダ)の中古車 | 中古車なら【カーセンサーnet】
RX-8】最後のロータリーエンジン搭載市販車!NA ロータリーエンジン +
その咆哮は787Bそのもの!」伝説の4ローター搭載FD3Sに迫る | web
RX8 4ローターほか | RSPANTERA 隊長のブログ
RX-8(マツダ)の中古車 | 中古車なら【カーセンサーnet】
RX-8(マツダ)の中古車 | 中古車なら【カーセンサーnet】
RX-8】最後のロータリーエンジン搭載市販車!NA ロータリーエンジン +
RX-7,RX-8などRE車を中心にレースからフィードバックしたノウハウをも
RX-8(マツダ)の中古車 | 中古車なら【カーセンサーnet】
RE雨宮 リア LED テールランプフィニッシャー CF D0-022030-214 マツダ
RX-8(マツダ)の中古車 | 中古車なら【カーセンサーnet】
オーバーホール・レストア | ロータリーエンジン、オーバーホール
NA仕様について
RX-8(マツダ)の中古車 | 中古車なら【カーセンサーnet】
エンジンオーバーホール
その咆哮は787Bそのもの!」伝説の4ローター搭載FD3Sに迫る | web
NA仕様について
ロータリーエンジンにも有効なエンジントリートメント! オイル添加剤
RX-8(マツダ)の中古車 | 中古車なら【カーセンサーnet】
4ローターRX-7レースカー」でレース体験できるプログラム参加募集中
Fine Tuning Rebuilt Engine | AutoExe マツダ車チューニング
RX-8】最後のロータリーエンジン搭載市販車!NA ロータリーエンジン +
RX-7のロータリーエンジンオーバーホール・ロータリーエンジン・STAYH
NA仕様について
R26B 4ローターロータリーエンジン
商品の情報
メルカリ安心への取り組み
お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます
出品者
スピード発送
この出品者は平均24時間以内に発送しています