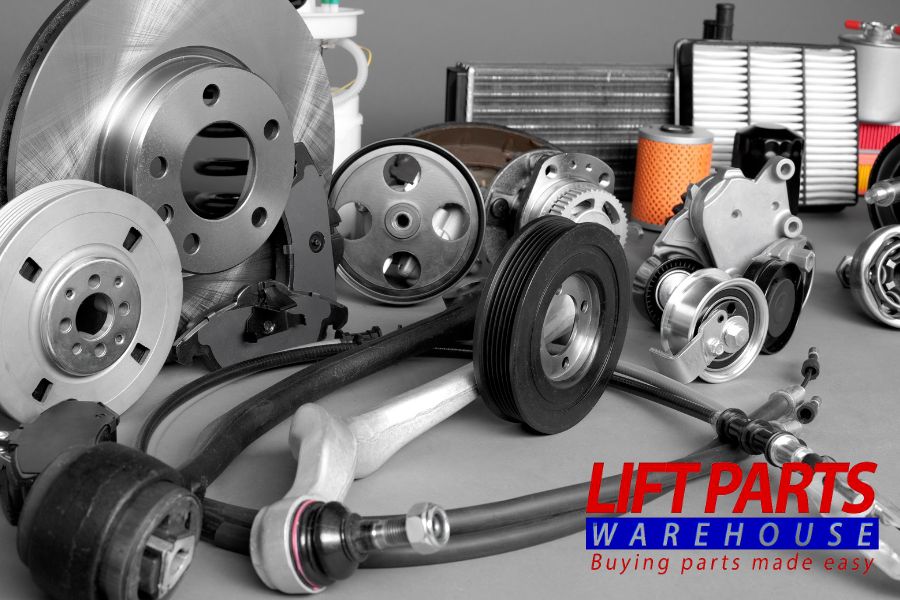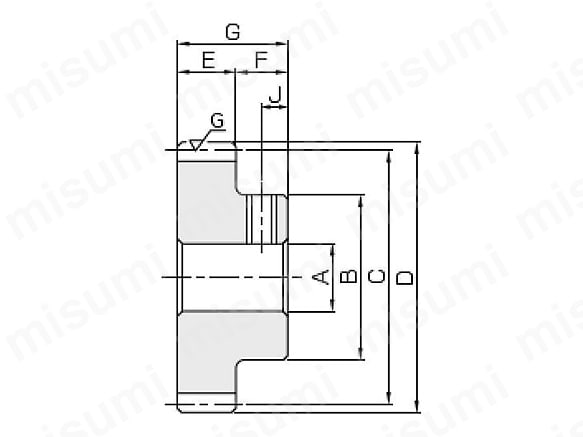KHK SSG1.5-50J25 歯研平歯車
(税込) 送料込み
商品の説明
商品情報
メーカー:小原歯車工業(株)
7011円KHK SSG1.5-50J25 歯研平歯車DIY、工具業務、産業用2022春夏 小原歯車工業 歯研平歯車 SSG2.5-45J25 1点 | www
在庫状況:メーカー別作品
納期:お支払い確認後、3〜4営業日で出荷予定(欠品時は早急にご連絡致します。)
商品特長:
●歯面焼入れした製品ですが、追加工が可能です。
用途:
●動力伝達用歯車。
仕様:
●モジュール:m1.5●歯数:50●形状:S1K●基準円直径(mm):75●歯幅(mm):15●穴径(mm):25●歯先円直径:78●全長(mm):29●ボス径(mm):60●ボス長さ(mm):14●タップ:M6●キー溝:8×3.3●ねじ穴位置:7●歯車精度:JIS B 1702-1 N7 級相当●歯面硬度:50〜60HRC●歯形:並歯●表面処理:歯部以外黒染(追加工部の再黒染はしていません。●)●圧力角:20°●歯面仕上げ:研削●歯切基準面:穴(H7)●熱処理:歯面高周波焼入れ●ねじれ角
材質/仕上:●S45C平歯車|歯研平歯車 SSG [Jシリーズ] | 小原歯車工業 | 製品情報
小原歯車工業 KHK SSG1.5-25通販】設備プロ王国公式通販
2022春夏 小原歯車工業 歯研平歯車 SSG2.5-45J25 1点 | www
2022春夏 小原歯車工業 歯研平歯車 SSG2.5-45J25 1点 | www
小原歯車工業 歯研平歯車 SSG1.5-23E15 1点-
SSG2-50J25 | SSG 歯研平歯車 | 小原歯車工業 | MISUMI(ミスミ)
KHK 小原歯車工業 SSG1.5-50J25 歯研平歯車 Jシリーズ : khk-ssg15
2022春夏 小原歯車工業 歯研平歯車 SSG2.5-45J25 1点 | www
SSG 歯研平歯車 | 小原歯車工業 | MISUMI(ミスミ)
小原歯車工業 KHK SSAG1.5-36通販】設備プロ王国公式通販
SSG4-60 SSG歯研平歯車 1個 小原歯車工業(KHK) 【通販サイトMonotaRO】
平歯車
小原歯車工業 歯研平歯車 SSG1.5-23E15 1点-
SSG 歯研平歯車 | 小原歯車工業 | MISUMI(ミスミ)
Jシリーズ|小原歯車工業株式会社
小原歯車工業 歯研平歯車 SSG1.5-23E15 1点-
小原歯車工業 平歯車 SS1.5-70 1点 - メカニカル部品
SSG2-50J25 | SSG 歯研平歯車 | 小原歯車工業 | MISUMI(ミスミ)
小原歯車工業 ラチェット SRT4-50J25 | LINEショッピング
平歯車|歯研平歯車 SSG [Jシリーズ] | 小原歯車工業 | 製品情報
平歯車
当店特典行き 小原歯車工業 歯研平歯車 SSG2.5-17J17 1点 - DIY・工具
KHK 小原歯車工業 SSA3-50J25 平歯車 Jシリーズ - 業務、産業用
小原歯車 KHK 歯研平歯車 SSG2.5-42E25 歯面高周波焼入 SSG Eシリーズ-
SSG 歯研平歯車 | 小原歯車工業 | MISUMI(ミスミ)
SS1-50 SS平歯車 1個 小原歯車工業(KHK) 【通販サイトMonotaRO】
小原歯車工業 歯研平歯車 SSG1.5-23E15 1点-
小原歯車工業 平歯車 SS1.5-70 1点 - メカニカル部品
小原歯車工業 ラチェット SRT4-50J25 | LINEショッピング
2022春夏 小原歯車工業 歯研平歯車 SSG2.5-45J25 1点 | www
福袋セール 小原歯車工業 KHK 仕様変更履歴|小原歯車工業株式会社 平
価格表
小原歯車工業 歯研平歯車 SSG1.5-23E15 1点-
SSG2-50J25 | SSG 歯研平歯車 | 小原歯車工業 | MISUMI(ミスミ)
平歯車
小原歯車工業 歯研平歯車 SSG1.5-23E15 1点-
小原歯車工業 ラチェット SRT4-50J25 | LINEショッピング
SS1-50 SS平歯車 1個 小原歯車工業(KHK) 【通販サイトMonotaRO】
SSG2-50J25 | SSG 歯研平歯車 | 小原歯車工業 | MISUMI(ミスミ)
2022春夏 小原歯車工業 歯研平歯車 SSG2.5-45J25 1点 | www
商品の情報
メルカリ安心への取り組み
お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます
出品者
スピード発送
この出品者は平均24時間以内に発送しています
![平歯車|歯研平歯車 SSG [Jシリーズ] | 小原歯車工業 | 製品情報](https://www.mekasys.jp/data/material/public/series/WEBCT-IMG200DPI/KHK_0008_P01.jpg)


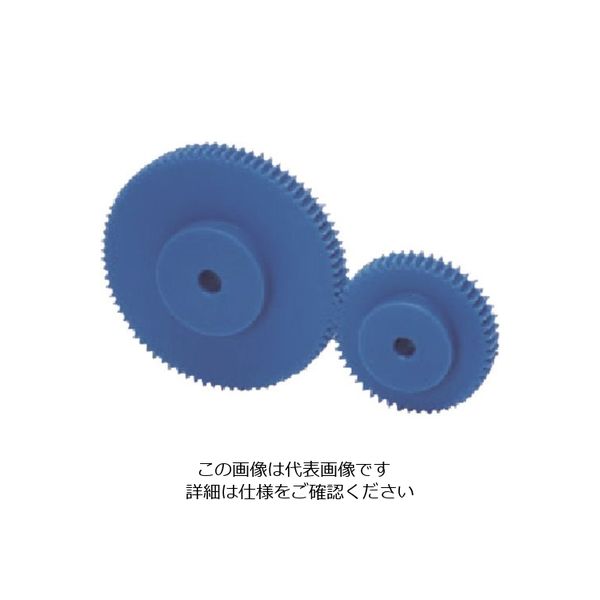












![平歯車|歯研平歯車 SSG [Jシリーズ] | 小原歯車工業 | 製品情報](https://www.mekasys.jp/data/material/public/series/WEBCT-IMG200X200/KHK_0009_P01.jpg)